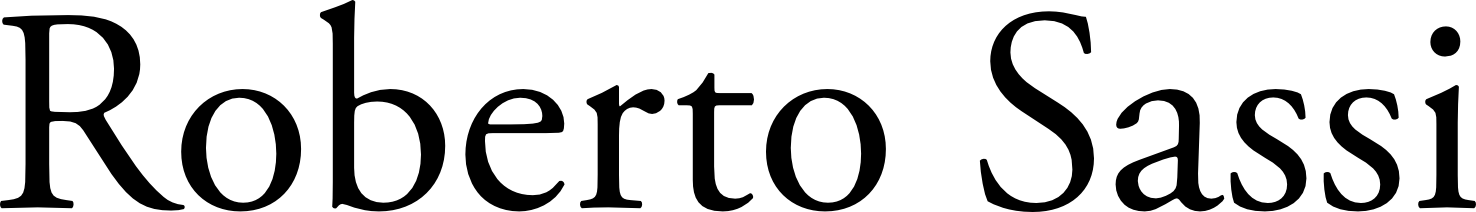Mentre leggevo L’impostore di Javier Cercas mi è tornato in mente un libro che ho letto anni fa, quando ero a Parigi, e che non c’entra niente né con Enric Marco, il grande bugiardo raccontato da Cercas, né con la storia spagnola dell’ultimo secolo né tantomeno con il campo di concentramento nazista di Flossenbürg, quello in cui per decenni Marco ha falsamente dichiarato di essere stato prigioniero. Mi è tornato in mente un romanzo scritto da Albert Camus nel 1956, che si intitola La caduta, e ha per protagonista un brillante avvocato parigino, Jean-Baptiste Clamence, che a un certo punto della vita si rende conto di essere vittima del suo ego smisurato, di mentire spudoratamente a se stesso e agli altri sul proprio conto, di essersi costruito un’immagine di uomo buono totalmente fasulla. Nel romanzo, che è poi un lungo monologo, Clamence molla tutto per trasferirsi ad Amsterdam, dove passa le giornate seduto al bancone di un bar malfamato, confessando agli avventori le proprie colpe – alcune vere, altre fittizie – con l’intenzione di far sentire i suoi interlocutori altrettanto colpevoli e così redimerli.
Leggendo L’impostore ho ripensato a un passaggio ben preciso, questo:
“In fin dei conti, che importanza ha? Le menzogne finiscono per mettere sulla strada della verità. E le mie storie, vere o false, non tendono tutte allo stesso scopo, non hanno lo stesso senso? Dunque, che importa se siano vere o false, poiché in entrambi i casi sono significative di quel che sono stato e di quel che sono? Talvolta si vede più chiaro in chi mente che in chi dice il vero. La verità, come la luce, acceca. Invece, la menzogna è un bel crepuscolo che dà risalto a ogni oggetto. Insomma, la prenda come vuole, ma io sono stato nominato papa in un campo di prigionia”.
Al di là del riferimento al campo di prigionia, la cosa sorprendente è che queste righe sono una delle possibili chiavi di lettura della storia di Enric Marco, e quindi del libro di Cercas. In un articolo dal titolo Il bugiardo che dice la verità, uscito sul Corriere della Sera il 21 gennaio 2007, un paio d’anni dopo lo smascheramento delle menzogne di Marco, Claudio Magris offre più o meno lo stesso spunto interpretativo. «Cosa succede», si chiede Magris, «quando la verità viene dalla bocca di un bugiardo, di un impostore che racconta cose realmente accadute e anzi contribuisce a diffondere, tramite le sue bugie, la conoscenza di una realtà terribile e rimossa, che riguarda il destino degli uomini e il senso della loro vita?». Già, cosa succede, si chiede Magris. E cosa dovremmo pensare noi di quella verità uscita dalla bocca di un bugiardo, aggiungo io. D’altronde, è forse proprio in questa domanda che risiede il grande fascino di Enric Marco e Jean-Baptiste Clamence, due bugiardi che, benché per ragioni assai diverse, sostengono di mentire per una giusta causa. E il fascino che esercitano Marco e Clamence è certamente parte del problema, perché ci invita implicitamente a interrogarci sui limiti della verità e della menzogna, sul confine tra le due, e sul diritto di valicarlo, questo confine.
Se Clamence, che è un personaggio letterario, può oltrepassarlo impunemente, può permettersi di diventare «giudice-penitente», accusandosi di ogni sorta di cattiva azione e giudicando gli altri per il solo fatto di essere come lui, Marco deve invece fare i conti con una realtà che non tollera bugie, specialmente su un tema tanto delicato come la deportazione. Così si ritrova a essere «il grande impostore e il grande maledetto», come lo definisce Cercas. Questo nonostante abbia contribuito con le sue verosimili bugie a diffondere una storia, quella sul campo di concentramento di Flossenbürg, che gli ormai troppo anziani e sempre meno numerosi ex deportati spagnoli non riuscivano più a raccontare con efficacia. A differenza di Marco, Clamence riconosce le proprie menzogne passate e ne utilizza di nuove per portare alla luce l’ambiguità di cui siamo tutti impregnati; mentre il finto sopravvissuto al campo di concentramento non accetta mai la verità, perché la considera meno significativa della menzogna che ha costruito.
È difficile non provare simpatia per Marco, per il suo tentativo di inventarsi una vita più soddisfacente di quella realmente vissuta, ed è difficile non accostarlo, come fa Cercas, al Don Chisciotte di Cervantes (che tra l’altro è anche lui un uomo di mezz’età quando si rifugia nell’invenzione). Tanto vale allora, un po’ per assolvere Enric Marco, un po’ per assolvere quella parte di noi che si ritrova a simpatizzare con lui, essere d’accordo con Mario Vargas Llosa, considerarlo un affabulatore capace di ricreare se stesso, una specie di romanziere. Perché, se si togliesse la finzione da romanzo, di Marco non resterebbe che il grande impostore e il grande maledetto. Ma se si togliesse la finzione, per coerenza bisognerebbe togliere pure il racconto di una realtà terribile che ha contribuito a diffondere con la sua impostura. Quindi, ripensando alle parole di Jean-Baptiste Clamence, viene da dire anche a me: in fin dei conti, che importanza ha?